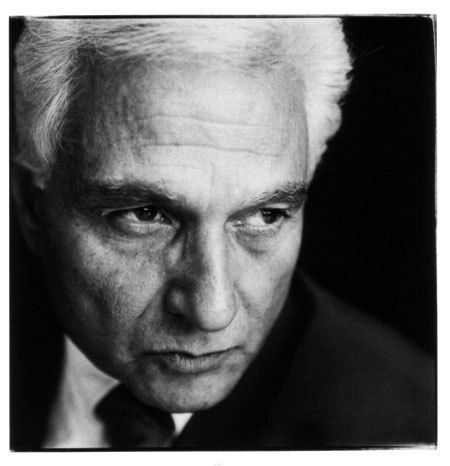I
CARATTERI DELLA SPIRITUALITÀ
Io ho nella mente, sempre, l’effetto di postulato dello scritto di Condorcet (matematico, economista, filosofo), Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humaine. Mi viene spontaneo descrivere quello che considero in fondo un racconto attraverso la formulazione di due principi, o assiomi: che se vi sono stati progressi dello spirito umano allora vi è stata storia; e prima ancora: che il fatto è progresso.
Alla storia, al
racconto, senza codesti principi, verrebbero come a mancare le ragioni e i
presupposti. Oppure sarebbe dato campo libero alla fantasia, al costrutto
poetico, figurandosi ancora uno gnomo, o un cavallo che raccontano dell'uomo,
scomparso dalla faccia della Terra, in un clima di dopo-storia e anche un po’
leopardianamente; per non parlare del puro e semplice ridire della eclisse del
sistema spirituale hegeliano (senza tenere conto del suo valore, storico-obiettivo),
le riflessioni di A. Kojève e di chi ne ha tratto alimento attribuendo l'unica
autorità, in fatto di teoria dello spirito, al filosofo tedesco. E ora dunque mi domando con riferimento al sette-ottocento: prima i francesi forse che i tedeschi, quali eccellenti sistematori?